Il politico conservatore Enoch Powell, in un discorso
all’autorevole Royal Society il 23 aprile 1961 pronunciò queste parole:
“La vita
ininterrotta della nazione inglese nell’arco di mille e più anni è un fenomeno
unico nella storia: il prodotto di un insieme specifico di circostanze come
quelle che in biologia si suppone diano inizio per caso a una nuova linea
evolutiva. […] Da questa vita ininterrotta di un popolo unito nella sua patria
insulare scaturisce, come se emergesse dal suolo d’Inghilterra, tutto
ciò che appare così straordinario nelle doti e nei successi della nazione
inglese. Tutto il suo impatto sul mondo esterno – con le prime colonie, la
successiva Pax Britannica, il governo e la legislazione, il commercio e il
pensiero – è scaturito da impulsi generati qui. Questa vita ininterrotta
dell’Inghilterra è simboleggiata ed espressa da null’altro se non dalla
sovranità inglese […] Il pericolo non è sempre la violenza e la forza: a esse
abbiamo resistito prima e possiamo resistere ancora. Il pericolo può essere
anche l’indifferenza e l’ipocrisia, capaci di dilapidare la grande ricchezza
della tradizione e svilire il nostro simbolismo sacro solo per raggiungere
qualche compromesso a buon mercato o qualche risultato evanescente”.[1]
Queste parole, che articolano in modo sintetico e mirabile, il
‘razzismo popolare’ così diffuso in Inghilterra è al fondamento del “nazionalismo
imperiale” che connette in un unico inestricabile insieme idee sulla razza,
senso di appartenenza ed ambizione di dominio. Si tratta di quello che
l’autrice chiama “imperialismo liberale”, o che Tony Blair chiamò “Nuovo
imperialismo liberale”, per giustificare nel 2003 la guerra in Iraq. Quella unione
indissolubile, nutrita di ‘bipensiero’ alla Orwell, di ‘totalità disumana’ e ‘promessa
di riforme’ che caratterizza l’universalismo liberale nella sua stessa
costituzione.
Confrontarsi con questa storia di pratiche e idee, è oggi
particolarmente importante, quando la mai scomparsa postura di legittimazione
del diritto (ed il fardello) di portare al mondo l’emancipazione e la ‘libertà’
riprende il suo posto centrale alla vigilia della nuova Grande Guerra che si
prepara e, per intanto, nelle “guerre locali” che proliferano.
Robert Cooper, consigliere di Blair per la politica estera disse
allora che nel mondo “postmoderno” la “vera sfida è abituarsi all’idea di due
pesi e due misure”. Con una franchezza meritevole di miglior occasione, Cooper
affermò che mentre in patria si trattava di operare in base alle leggi, negli
“stati più antiquati, al di fuori del continente postmoderno dell’Europa,
dobbiamo tornare ai metodi più rudi di un’epoca precedente”. Cioè “alla forza,
all’attacco preventivo, l’inganno”. Specificamente, “tutto ciò che è necessario
per affrontare coloro che vivono ancora nel mondo ottocentesco di ogni stato
per sé”. In parole ancora più crude: “tra noi rispettiamo la legge, ma quando
operiamo nella giungla, dobbiamo usare anche le leggi della giungla”. Per
giustificare l’intervento nella ex-colonia, come oggi a ben vedere per
giustificare ogni macelleria in grande stile che, di volta in volta, si rende
purtroppo “necessaria”, l’onesto Cooper non si fece scrupolo di richiamare il
colonialismo. Leggiamo ancora:
“Il modo più
logico per affrontare il caos, nonché quello maggiormente utilizzato in
passato, è la colonizzazione. Essa è tuttavia inaccettabile per gli stati
postmoderni (e, a quanto pare, anche per alcuni stati moderni). È proprio a
causa della morte dell’imperialismo che stiamo assistendo all’emergere di un
mondo premoderno. Impero e imperialismo sono parole che nel mondo postmoderno
evocano una forma di abuso. Oggi non ci sono potenze disposte ad assumersi
l’onere di una colonizzazione, anche se le opportunità in tal senso. E forse
anche la necessità, sono forti come lo erano nel XIX secolo”[2].
Queste parole non sono pronunciate, come molte che vedremo, nel
XVIII secolo, e neppure nel XIX o XX, sono nostre contemporanee. E non
sono pronunciate da populisti con la bava alla bocca, bensì dal civilizzato e
di “sinistra” governo inglese, alleato strettamente con il neoconservatore
governo americano; sono pronunciate davanti alle antichissime porte di Bagdad.
Queste parole crude (che poi si articolano a seconda dei casi nel
neoimperialismo soft, o informale, dell’economia globale controllata con il
‘pilota automatico’ dagli organismi finanziari internazionali, o, quando la
sfida si fa stringente, nel neoimperialismo hard, in piena aria, delle guerre
per procura tramite terzi) incarnano l’imperialismo liberale, che si sforza di
“Take Back Control” (lo slogan conservatore di Farange) o “Make America Great
Again” (lo slogan di Trump). Parole che si accompagnano, secondo una
sistematica di lungo tempo, con le promesse di libertà e universalismo.
Il “Giano bifronte” del liberalismo è l’oggetto di questo libro.
Si tratta di un testo imponente, scritto da Caroline Elkins, una
delle più importanti e rispettate specialiste della storia imperiale
britannica, docente di Storia e Studi Africani e Afroamericani ad Harvard e
consulente del tribunale inglese in un recente ed importante caso giudiziario,
il quale illustra nel corso di quasi ottocento pagine (più 200 di bibliografia
e note) come di fatto l’inestricabile groviglio tra liberalismo, violenza,
legge e creazione di appropriate tesi storiche ideologiche abbia contribuito
nel corso della storia a sedimentare in gran parte del mondo contemporaneo una
particolare cultura della sopraffazione vestita di abiti civili. Una
cultura che è transitata nei volenterosi allievi statunitensi, poi fattisi
maestri, e di qui divenuta marchio di fabbrica dell’Occidente verso il resto
del mondo.
La centralità della vicenda britannica è pari, nel mondo moderno,
a quella dei romani e greci nel mondo antico; chiaramente strutturante e punto
di riferimento, sia nella prima fase sei-settecentesca (quando si svolse con
mezzi informali e secondo lo svolgimento del “libero mercato”), sia nella
seconda otto-novecentesca (quando la crescita della concorrenza obbligò a
passare al modello della ‘clausola imperiale’ per continuare a garantire che
gli investimenti restassero senza concorrenti, l’importazione di cibo e merci
privilegiata e lo spazio finanziario della sterlina al sicuro).
Complessivamente i britannici invasero o conquistarono 178 paesi e
nel solo XIX secolo promossero 250 conflitti armati e controinsurrezioni.
Quelle che Kipling definì “le barbare guerre per la pace”, in una
splendida applicazione del “pensiero doppio”[3]
orwelliano.
Nell’impero britannico il colore della pelle divenne quindi il
segno della differenza, secondo una ben precisa gerarchia razziale, ma la pelle
era in realtà un segno ‘costruito’. Di volta in volta potevano essere “neri”
anche gli irlandesi, i palestinesi e gli ebrei, gli afrikaner olandesi, in una
classificazione che si sovrappose ed implicò un giudizio unilaterale circa il
livello di “modernità” e “maturità” rispetto ad un’implicita scala del
progresso, secondo i rigidi parametri della filosofia della storia
dell’Occidente. O, in altri termini, secondo la sua idea di “libertà” e di
“Stato di Diritto”. Questa è, per l’autrice, la “Sideologia del liberalismo
liberale”, che con le sue rigide camicie di nesso intrappola le menti ed i
cuori degli attori imperiali e integra le loro rivendicazioni sovrane. Ne
derivò per la Gran Bretagna un massiccio impegno a “riformare” i sudditi e
accompagnarli, come un gregge talvolta recalcitrante, nel mondo moderno. Si
tratta del famoso “fardello dell’uomo bianco”[4].
Questo è il tema, centrale da un certo punto dello svolgimento
della storia, dello “sviluppismo” che cominciò a vedere i barbari, con una
condiscendenza autopercepita come generosa, come bambini da far maturare. Ne
derivò l’assunzione di una “missione civilizzatrice” di cui la violenza fu da
sempre sia il mezzo sia il fine. Nel corso del XIX secolo l’intera missione,
nel transitare l’Impero nel regno dello Stato di Diritto, si innervò di codici
e procedure che non fecero altro che legittimare e giustificare la violenza e
proteggere i suoi autori. Ma per questa via, tra “missione” e “legge”,
l’imperialismo liberale metteva ai suoi avversari in mano le armi del suo
disfacimento. Un bambino prima o poi deve crescere, anche se, nel frattempo è
giusto sia esposto alla dura disciplina, alla punizione, visibile e educativa
per il suo bene. L’apice di questo disfacimento si ebbe subito dopo la II WW,
nelle condizioni particolari generate dalla crisi economica britannica, che la
rendeva contemporaneamente dipendente dall’Impero e non più finanziariamente
indipendente nel sostegno della sterlina, dalla complessa relazione con gli
Stati Uniti, determinati a porre fine alla centralità britannica, ma bisognosi
del controllo imperiale in chiave antisovietica, e il movimento terzomondista
che prendeva in parola le parole d’ordine istituite nell’immediato dopoguerra e
via via istituzionalizzate in organismi internazionali e solenni
“Dichiarazioni”.
Insomma, il libro mostra come, con le parole dell’autrice: “la
violenza era connaturata al liberalismo. Risiedeva nello stesso riformismo
liberale, nelle sue pretese di modernità e nelle sue concezioni della legge:
elementi, di fatto, opposti a quelli normalmente associati alla violenza”[5].
Non si è trattato solo di sfruttamento economico, e non solo di “capitalismo
razziale”[6],
ma di un legame interno tra liberalismo e violenza (un legame logico e
storico) che è presente anche nelle questioni razziali (e geopolitiche)
contemporanee. Anche oggi i popoli “neri” sono allineati sulla linea del
progresso, rappresentato dalla maggiore o minore vicinanza ad un modello
soprastorico (ne è un esempio la Russia, nerissima, mentre l’Ucraina è, per
ora, bianchissima, e via dicendo, ora stanno diventando bianchi anche i
‘ribelli’ siriani e ‘neri’ come sono sempre stati i lealisti).
Secondo il racconto, nell’impero di fatto coesistevano per tutta la sua durata, e spesso teorizzati, sistemi duplici di autorità e legittimazione: leggi consuetudinarie in patria e codici coloniali fuori. Monopolio della violenza in entrambi (che non cedette neppure al cosiddetto “governo indiretto”, a volte praticato quando considerato più economico). Era la “missione civilizzatrice” che implicava, e necessariamente, sia una dimensione progressista sia una dimensione coercitiva. In effetti, “riforme e repressione erano connaturate sia al linguaggio [dell’imperialismo liberale] sia ai suoi sistemi. Il perenne gioco universalista sullo sfondo delle differenze razziali [ovvero di grado di civilizzazione] si riproducevano a catena”[7].
Anche dopo la I WW, con il sistema del “mandati” che sostituì una
“amministrazione fiduciaria” al vecchio dominio diretto, nominalmente
sorvegliata dalla “Società delle Nazioni”, non portò modifiche sostanziali. I
popoli “non ancora capaci di reggersi da sé, nelle difficili condizioni del
mondo moderno”, secondo la formula giuridica applicata, restarono sottomessi,
ovviamente per il loro bene.
Tuttavia, nella II WW, la mobilitazione senza precedenti dei
popoli coloniali come soldati e come forza lavoro rese necessario fare promesse
che, in seguito, restarono sospese. Ed allora la difficile relazione con gli
Stati Uniti e il loro approccio (insieme storico-culturale e di interesse)
antimperialista, unita alla dipendenza economica, resero necessario per la Gran
Bretagna rivestire la sostanza coloniale di nuove idee, le quali sfidarono in
modo crescente il “bipensiero” imperiale. In conseguenza la “amministrazione
fiduciaria” diventò “partnership”, verso il “benessere comune” (Commonwealth).
Ma nella Carta delle Nazioni restò la definizione di “territori la cui
popolazione non ha ancora raggiunto la piena autonomia” e per i quali è quindi
necessario garantire, con le buone o le cattive, il “progressivo sviluppo”. Ne
derivò una tensione strutturale, presa tra le necessità economiche di
utilizzare le aree protette coloniali per alimentare la rinascita economica e
le belle parole, tra pretesi diritti universali e discriminazione razziale (che
è, in realtà, discriminazione rispetto alla conformazione al modello
universale).
 |
| Lizzie van Zyl, bambina boera morta nel 1901 di denutrizione |
Il testo è, un orrendo resoconto, frutto di decenni di lavoro di archivio, delle atrocità che solerti funzionari e militari britannici compirono in tutte le aree di sollevazione dell’impero, in Africa (dalla guerra boera a quella keniota) in Medio Oriente (con il caso palestina in evidenza), in Oriente (dall’India alla Malesia, e via dicendo), senza dimenticare la palestra irlandese, o la vicenda cipriota. Vicende che giunsero al culmine tra gli anni Cinquanta e Sessanta, ma poi proseguono in Vietnam ad opera degli allievi Americani.
L’Impero Britannico, insomma, assunse una configurazione sempre
più violenta nel tempo, man mano che da una parte esaltava le virtù del
liberalismo, per difendere un dominio che appariva sempre più obsoleto,
dall’altra era costretto a legittimare internamente ed esternamente gli episodi
di estrema coercizione come sfortunate eccezioni al trionfo evolutivo della modernità.
Questa è la forma che prende il “Nazionalismo Imperialista”
che, lascito di lungo periodo del colonialismo britannico, permane e
continuamente riemerge nell’attuale Gran Bretagna. E non solo.
Una
delle cose che occorre comprendere è che spunti progressisti e azione
coercitiva sono entrambi espressione della medesima, autoattribuita,
“missione civilizzatrice”. L’imperialismo liberale può sempre tollerare
contestazioni perché riforme e repressione sono parte del suo linguaggio e dei
suoi sistemi operativi.
Parte Prima: Una nazione imperiale.
La prima scena descritta nel libro è quella della conquista
dell’India, gioiello dell’Impero, da parte della Compagnia delle Indie Orientali[8] che
sfrutta un episodio del 1756 (la cattura
di alcuni inglesi e la detenzione nel cosiddetto “Buco nero di Calcutta”) per
giustificare l’attacco militare al Bengala e la battaglia di Plasey, del 1757,
che dà l’avvio alla sistematica presenza inglese, Dai Moghul viene concesso il
diritto di riscuotere le tasse che porterà somme enormi al tesoro inglese, ma,
a causa di pratiche di selvaggio sovrasfruttamento, anche un’immane carestia
nella quale si stima siamo morti circa 10 milioni di persone (un terzo della
popolazione). Questo effetto non voluto portò, tuttavia, ad una caduta delle
entrate e la Compagnia sull’orlo della bancarotta; a sua volta questo provocò
un crollo del credito a livello globale. In questo contesto fu concesso un
prestito di 1,4 milioni di sterline, e fu sostituito il Governatore, da Clive
ad Hastings. Quest’ultimo fu poi richiamato per subire un processo che è, in
effetti, la scena madre di alcune delle strutture discorsive ricorrenti. Il
processo in Parlamento vide Edmund Burke impegnato per l’accusa. La linea
tenuta mise in effetti sotto giudizio la legittimità dell’impero, richiedendo
standard superiori. Secondo Burke l’impero si giustifica per il benessere dei
sudditi e la creazione di uno Stato di Diritto. La Gran Bretagna aveva la sacra
missione di istituire un governo degno e responsabile, che comprendesse anche
le tradizioni locali aiutandole ad evolvere in direzione della modernità[9].
 |
| Edmund Burke |
In uno straordinario passaggio retorico del Discorso di Apertura,
il 15 febbraio 1788, Edmund Burke, davanti alla Camera dei Lord, pronuncia la
verità che il processo dovrebbe dissolvere:
“Dio non
voglia che all’estero si diffonda l’idea che le leggi dell’Inghilterra sono
fatte per i ricchi e i potenti invece che per i poveri, i miserabili, gli
indifesi che non si possono permettere alcun’altra protezione. Dio non voglia
che si dica che in questo regno sappiamo assegnare ai funzionari pubblici
poteri estremamente ampi e incontrollabili e abbiamo mezzi scarsi, inefficaci,
manchevoli e impotenti per richiamare in giudizio chi ne abusa. Dio non voglia
che si dica che al mondo non c’è nazione pari alla Gran Bretagna per
concretezza della violenza e irregolarità della giustizia. Non si dovrà mai
dire che – per coprire la nostra responsabilità nel saccheggio dell’Oriente – abbiamo
inventato un insieme di distinzioni scolastiche contrarie al sentimento di
umanità, per mezzo delle quali fingere di non sapere ciò che il resto del mondo
sa bene e sente”[10].
In un discorso che durò quattro giorni il filosofo e politico inglese
accusò Hastings di “moralità geografica”, ovvero che “una volta superata la
linea equatoriale, tutte le virtù morissero”. Al contrario, le leggi morali
“sono le stesse ovunque”. Questa idea, dell’universalità dei diritti umani, in
quanto “naturali” era in effetti una delle grandi idee del secolo, che si
sarebbe affermata attraverso le due rivoluzioni “atlantiche” (anzi le tre[11]).
L’assoluzione, dopo nove anni e oltre 170 sedute, di Hastings
lasciò comunque due eredità: che la Compagnia doveva rispondere alla corona, e
che la sacra responsabilità della Gran Bretagna nei confronti dei popoli
sottomessi non poteva essere ignorata.
Si rendeva necessaria una più articolata giustificazione del
dominio. Altri grandi intellettuali, come James Mill vi si impegnarono. Una
linea da perseguire era quella di descrivere l’altro come deficitario e quindi
bisognoso di tutela, ovvero come antitesi della civiltà. D’altra parte,
come ricorda opportunamente la Elkins il pensiero liberale si è evoluto in
Europa intersecandosi sin dall’inizio, ovvero da cinque-seicento, con il lungo
processo dell’ascesa degli imperi (prima spagnolo e portoghese, poi francese e
inglese, olandese) in un rapporto che qualifica come “reciprocamente
costitutivo”.
Anche se questa tesi richiederebbe maggiore esplicazione, di
fatto comporta una coevoluzione delle idee stesse di libertà, progresso e
governo. L’espansionismo, ideologico e materiale, è, insomma, connaturato
nei tratti distintivi del liberalismo, e con esso le nozioni universalistiche
di progresso e le rivendicazioni morali, tutte strettamente connesse con
l’espansione della proprietà e del capitale come ordinatore centrale
della società. Deriva da tale postura, che ha radici profondissime[12],
che talvolta nei confronti delle “razze minorenni”, secondo la fortunatissima
formula di Jhon Stuart Mill, il dispotismo può essere “necessario”.
L’organizzatore ulteriore della razza viene rafforzato via via
dagli episodi che si susseguono, tra i quali si può ricordare la ribellione dei
Sepoy, e la Commissione di inchiesta composta da Mill, Darwin e Herbert
Spencer, che vede a difesa della legittimità dell’Impero impegnarsi Dickens,
Jhon Ruskin e Thomas Carlyle. In questo scontro di giganti della cultura
inglese viene messa a punto l’idea che, contrariamente a quanto sostenuto da
Burke, i diversi stati di sviluppo devono comportare l’applicazione di
diversi livelli legali. Si tratta di un cambiamento epocale[13].
Intorno all’apprendimento reso dagli eventi giamaicani è ampliata la
possibilità di ricorrere alla violenza, come base stessa del diritto. L’Impero
comincia ad essere concepito come impresa patriottica totalizzante.
Tutti questi momenti convergono nella grande sintesi di Disraeli,
che attraverso l’evento simbolico e il grande spettacolo dell’incoronazione
della regina Vittoria, determina un legame duraturo tra l’orgoglio nazionale e
la “missione civilizzatrice” autoassunta. In letteratura è la stagione di
Caroll, George Alfred, Kipling, Selley.
 |
| Benjamin Disraeli |
Ma non è solo una questione culturale, o politica. In realtà per
mantenere la sua posizione di leader finanziario mondiale, e favorire
l’affermazione del capitalismo nel paese, la Gran Bretagna deve assicurarsi un
flusso costante di oro. Ad ostacolare questo processo gli afrikaneers,
discendenti dei primi coloni olandesi e insediati nel cruciale sud Africa.
Quando si scopre l’oro nel Transvaal, nel 1806, migliaia di inglesi e
imprenditori senza scrupoli, si riversano regione. Il presidente dei Boeri, Paul
Kruger impone regole che rendono difficili gli insediamenti coloniali inglesi,
e ciò porta a lunghi decenni di attriti che, alla fine, scaturiscono in guerre.
La Seconda guerra anglo-boera è del 1899, quando per risolvere la cosa la
corona invia 75.000 uomini in una “missione di civiltà”. Una “missione” che si
amplifica costantemente, fino ad arrivare a impegnare 450.000 soldati, di cui
22.000 morirono e 75.000 restarono invalidi. Durante questa guerra prende il
via il solito processo di deumanizzazione degli avversari che, per Kipling,
sono una “mezza casta” e vengono affrontati via via con mezzi sempre più
radicali. Sarà il generale Kitchener, reso famoso per l’aver sconfitto in Sudan
le forze di Al-Mahdi, che proporrà una soluzione drastica per contrastare
l’abilissima guerriglia dei boeri: divise il territorio con fortificazioni e
filo spinato e realizzò campi di prigionia di massa nei quali anche le donne e
i bambini erano dichiarati obiettivi legittimi. Fu in assoluto la prima volta
che un intero gruppo etnico era soggetto a deportazione ed internamento di
massa. I campi di concentramento di Kitchener furono osservati in tutto il
mondo con interesse, in particolare in Germania.
 |
| Horatio Herbert Kitchener |
Dall’altra parte militava Jon Smuts, una personalità realmente
straordinaria, a capo dei commando afrikaner e che poi diventerà uno dei
principali architetti delle trasformazioni imperiali nelle fasi successive.
Durante la guerra furono sperimentate anche armi proibite come le micidiali
pallottole dum-dum.
Il prossimo sito di scontro, e luogo di apprendimento, fu
l’Irlanda, in cui si misero a punto tattiche e regolamenti che poi saranno
esportati in tutto l’Impero. Nel 1916, alla fine della I Guerra Mondiale,
Patrick Pearse occupò con un colpo di mano l’Ufficio Postale di Dublino. Per
risolvere la crisi Kitchener, ormai Segretario alla Guerra, mandò il generale
John Maxwell, nominandolo Governatore militare dell’Irlanda. La repressione fu
feroce, in pochi giorni furono uccisi 500 civili, e i leader furono catturati e
giustiziati. Invece di sedare la cosa, questo fece cambiare direzione
all’opinione pubblica. Il sacrificio di Pearce accese la miccia nella quale
emersero nuovi leader militari, forgiati nelle lotte degli afrikaaners; tra
questi Michael Collins che portò l’enorme esperienza della guerra di guerriglia
ad un nuovo livello. La guerra di indipendenza irlandese portò il governo di
Lloyd George alla decisione di far arrivare altri 10.000 uomini sull’isola e a
far nascere le famigerate unità dei “Block and Thanks” che alzano enormemente
il livello di violenza. Il risultato fu, però, solo che crebbe enormemente
anche il reclutamento nell’IRA.
 |
| Michael Collins |
Nel frattempo, Smuts, ormai convinto della necessità per il
Sudafrica di rimanere con l’Impero per portare a termine la missione di
civiltà, contribuisce alla definizione nella Società delle Nazioni del concetto
dei “Mandati”. Per cui la colonizzazione poteva continuare, su Mandato della
Società, per il tempo necessario a che il paese bambino crescesse. Venivano
definiti anche Mandati di diversa classe, secondo il grado di maturità: A o B.
L’India era sottoposta ad uno di questi “mandati”, ma fu subito
soggetta a numerose rivolte. Uno dei punti di definizione fu la strage del
Parco Bagh, quando l’ufficiale inglese, Reginald Dyer, fece aprire il fuoco su
una folla pacifica, uccidendo 400 persone e ferendone 1.200. La rivolta terminò
con la condanna di 581 persone e l’esecuzione di altre 108. Chiamato a
risponderne Dyer giustificò i suoi provvedimenti come “necessari” ed
appropriati. La violenza aveva, infatti, un “effetto morale” salutare. Nel
processo che seguì i laburisti si mossero all’attacco e Churchill produsse
un’abile difesa che lo restringeva ad un “orribile episodio isolato” che non
comprometteva “l’augusta e venerabile struttura dell’Impero Britannico, in cui
l’autorità legittima si tramanda di mano in mano e di generazione in
generazione” e che “non ha bisogno di ricorrere a cose simili”, in quanto “tali
idee sono assolutamente estranee al modo di fare britannico”[14].
In realtà la causa ottenne effetti di legittimazione della violenza, in quanto
mostrò un sentimento di appoggio all’ufficiale in tutti i ceti sociali e radicò
la violenza “necessaria” dell’Impero nei concetti di dovere, onore, nella
difesa dell’Impero e di conseguenza della nazione.
L’insurrezione in Iraq inaugurò nuove tecniche di
controinsurrezione, ovvero un nuovo livello di terrorismo. Arthur “bomber”
Harris ne fu l’eroe. Dal 1920 fu messa a punto una tecnica di bombardamento
areo indiscriminato che colpiva sistematicamente i villaggi isolati, più o meno
indicati come “ribelli” dalla nascente intelligence imperiale. Si tratta della
tattica della “violenza e terrore” dal cielo, come la chiamò un giovane Wiston
Churchill. Attacchi continui, giorno e notte, con dardi aerei, gas, bombe al
fosforo, razzi, bombe ritardate, semplici granate, e greggio per contaminare
l’acqua.
Più o meno nello stesso anno prende avvio la “questione
palestinese”, nella quale sono impiegati membri della ex polizia irlandese.
Inizialmente l’Alto Commissario in Egitto promette sostegno ai palestinesi, ma
Lloyd George, divenuto premier, cerca un accordo con gli ebrei. È allora che
Chaim Weizmann riesce a far sembrare il frammentato mondo sionista come se
fosse forza unitaria e decisiva, e quindi “la Palestina come focolare nazionale
per il popolo ebraico”. Sarà questo il contesto della “Dichiarazione di
Balfour”, che è resa possibile dalla intermediazione di Wilson verso Lloyd
George. La reazione dei nazionalisti arabi fu l’innesco dello scontro sul muro
di Gerusalemme, che vide il nuovo ufficiale inglese, Duff, applicare la cultura
dei “Black and Tanks”. Una violenza indiscriminata che fu, tuttavia, ampiamente
giustificata davanti alle critiche ricevute in patria. Sarà l’affermazione di
Ben Gurion e l’assassinio del leader arabo Al-Qassam a portare lo scontro ad un
livello insostenibile. Un livello di illegalità generalizzata da tutte le parti
in conflitto, e da parte inglese. Vengono importate nuove tattiche di
interrogatorio (direttamente dalla famigerata prigione “Cellular Jail” del
Bengala. Charles Tagart crea centri di detenzione e tortura distribuiti e fuori
vista ed un muro lungo 80 km. Nell’estate del 1938 la rivolta araba aumenta ed
arriva il mitico capitano Orde Wingate, il quale crea le “squadre speciali
notturne”, che per i critici “puzzano di Gestapo”.
 |
| Orde Wingate |
Parte Seconda. L’impero in guerra.
La Seconda Guerra Mondiale è il punto di svolta di tutte le
tendenze. L’avvio è disastroso, i Giapponesi, con irrisoria facilità, prendono
la “fortezza Singapore”, catturando 130.000 soldati inglesi e uccidendone
10.000.
La necessità di mobilitazione porta i leader politici a fare
promesse di liberazione generale che, nel dopoguerra, si ritorceranno contro di
loro. Chamberlain dichiara che l’obiettivo della guerra è sconfiggere l’intera
mentalità aggressiva e prepotente che cerca di dominare gli altri popoli con la
forza. Lui pensa ai tedeschi e giapponesi, altri penseranno agli inglesi.
La guerra viene posta in termini di evangelizzazione, in quanto
“cristianesimo, civiltà occidentale, democrazia e stato di diritto” sono
tutt’uno. Ancora, c’è chi ascoltate queste parole penserà che democrazia
significa autodeterminazione.
La spinta essenziale che determinerà lo sdoganamento del tema
della autodeterminazione e quindi della decolonizzazione, del resto ormai maturo,
arriva dagli Usa, ed è imperniato nella retorica che la coppia Roosevelt, marito
presidente e moglie, promuovono per ragioni geopolitiche non meno che ideali.
Si tratta delle famose “quattro libertà essenziali”. Quella di parola,
di religione, dal bisogno e dalla paura. Viene sbandierato l’ideale della “cooperazione
di paesi liberi, che lavorano insieme per una società amichevole e civile, … la
libertà significa la supremazia dei diritti umani ovunque”[15].
 |
| Eleanor Roosevelt |
Tra i due alleati inizia un fitto e complesso rapporto, che vede
da una parte la determinazione americana a indebolire il ruolo della sterlina
nel dopoguerra, per sostituirla con il dollaro, e quindi per essa l’impero
commerciale e coloniale inglese (per cui, ad esempio, in cambio dell’indispensabile
petrolio è pretesa la cessione di basi militari coloniali), mentre dagli inglesi
la resistenza a tale ipotesi, per paura che la riduzione del loro impero
comportasse l’ascesa di quello americano (come sarà).
Questo è il contesto della scrittura, imposta dagli americani e
accettata dagli inglesi pensando in sostanza alla sua applicazione solo all’Europa
occupata dai nazisti, della “Carta atlantica”. Viene pronunciata
solennemente la promessa di rispettare il diritto di tutti i popoli e i relativi
diritti sovrani e di autogoverno. Dunque, mentre l’Inghilterra ha un disperato
bisogno dell’aiuto americano per sopravvivere alla pressione tedesca, e quindi
accetta di scambiare basi per petrolio, l’Accordo di Ottawa e la Carta
Atlantica, gli americani puntano, evidentemente, ad aprire i commerci (avendo
l’economia più forte), e quindi eliminare la “preferenza imperiale”.
Questa è la retorica, ormai visibile, che viene sfidata dal basso
da una nuova generazione di intellettuali periferici, formati nelle università
del centro, e dall’altro da Roosevelt, il quale dichiara finita “l’età
dell’imperialismo”. Simili dichiarazioni ottengono un effetto particolare sui
movimenti di liberazione coloniale e i loro attivisti, come Padmore. Da una
parte aprono speranza, dall’altra consigliano una postura meno radicale e
disperata, attenuare il linguaggio di denuncia ed enfatizzare, piuttosto, il
concetto di “autodeterminazione dei popoli” ed il suo nesso con il benessere. In
altre parole, tradurre le rivendicazioni nel linguaggio educato, e ‘civilizzato’,
dei “diritti”.
Al momento agli alleati, però, per vincere l’Impero serve: l’India
contribuisce con 2.250.000 soldati, ma anche con una crescente
industrializzazione di guerra. Per ottenerlo sono aperti negoziati con la Lega
Mussulmana, da una parte, e il Congresso Indiano, dall’altra. Proprio in questo
momento Gandhi lancia una campagna di disobbedienza civile che sfugge di mano
ai proponenti e diventa molto rapidamente una rivolta di massa, subito repressa
nel sangue dagli Inglesi, lo stesso Mahatma vie arrestato e rilasciato solo nel
1944, per paura che possa morire in carcere, dove nel frattempo si era
ammalato. Dall’altra parte della barricata Bose che l’Ina, un esercito di oltre
300.000 combattenti indiani che lotta contro gli inglesi, appoggiato ed armato
dai giapponesi.
Mentre il mondo è immerso nella guerra, emergono autori come Nnamdi
Azikiwe, autore di un trattato sulla “Rinascita africana”[16],
Eric Williams “Capitalismo e schiavitù”[17], Robert
James scrive “Giacobini neri”[18],
William Du Bois “Le anime del popolo nero”[19],
Aimé Cesaire “Discorso sul colonialismo”[20],
Franz Fanon “Pelle nera, maschere bianche”[21] e
“I dannati
della terra”[22],
George Padmore. “The life and struggles of negro toilers”[23], “How
Britain Rules Africa”[24], “Africa
and world peace”[25]. Insieme
avviano un complessivo ripensamento delle condizioni della loro soggezione, focalizzando
“l’empia alleanza tra capitalismo, razzismo e colonialismo”[26]. Ovvero
la doppia capacità del liberalismo di emancipare e insieme reprimere, di
illuminare e nascondere alla vista. Essenzialmente offuscando e
giustificando la violenza con la retorica della missione civilizzatrice. Cioè con
la lettura dell’impero paradossalmente come libertà, se non subito almeno in
fieri, e secondo la presunta capacità di portare la civiltà alle razze
minori del mondo. Il dominio imperiale come azione di emancipazione e libertà
che, per i suoi propagandisti, non si era affermato con una vera e propria
violenza, in quanto si era semplicemente e naturalmente esteso in aree “vuote”.
Questa idea che l’altro sia “vuoto”, e quindi disponibile ad accogliere il “pieno”
portato dall’Occidente (casomai con mezzi coercitivi a fin di bene), è una
delle più resistenti eredità del colonialismo anglosassone.
Reginald Coupland, autore di libri come “Zulku battle piece:
Isandhalawana”[27] e
“India a re-statement”[28], promosse
ad esempio l’idea che l’impero manifestava l’equità, se non addirittura l’umiltà
con la quale il fardello dell’uomo bianco era portato nel mondo, gratificando
le razze minori del dono della umanità e civiltà. Insomma, per questa
impostazione, l’essenza del dominio imperiale britannico risiedeva nell’espansione
della libertà costituzionale, e, insieme, nello spiegamento del potere
civilizzatore. Con il suo portato di lavoro libero (ovvero salariato) anziché schiavizzato,
al libero scambio ed un sistema di governance e legislazione privo di quelle
caratteristiche di dispotismo e barbarie che, invariabilmente, affliggevano da
sempre le razze per questo “minori” del mondo.
Anche se talvolta senza questa precisione, questa è l’idea che
permane anche oggi e di manifesta invariabilmente ogni qual volta qualche razza
“minore”, o “bambina”, si oppone al buon padre che è incarnato nel magnanimo Occidente.
Si tratta di quello che Gorge Orwell, da decenni fermo oppositore
interno dell’imperialismo inglese, chiama nel finire della sua vita “doppio
pensiero”. Nel 1948 scrive, quando ormai si è arreso alla progressione della tubercolosi
che lo ucciderà dopo sette mesi dalla pubblicazione, il suo romanzo più famoso,
“1984”[29],
è letto dalla Elkins come denuncia dell’imperialismo inglese (anziché della
dittatura comunista, come spesso è interpretato). Esso, infatti, esplora le
conseguenze del totalitarismo e dell’imperialismo liberale, dove, come nella Oceania
del libro, “la guerra è pace” e “la libertà è schiavitù”. È il “Doppio pensiero,
che implica la capacità di accogliere simultaneamente nella propria mente due
opinioni tra loro contrastanti, accettandole entrambe. L’intellettuale di partito
sa in che direzione vanno alterati i ricordi e dunque sa che sta facendo tiri
mancini alla realtà, ma grazie al bipensare si persuade anche di non violarla”[30]. Si
tratta di “usare l’inganno in modo consapevole”, evitando al contempo un “senso
di falsità, dunque di colpa”. Qualcosa che è conscio ed inconscio allo stesso
tempo e che richiede un lungo addestramento. Con le parole di Orwell nel romanzo,
“dire intenzionalmente delle menzogne mentre ci si crede con sincerità,
dimenticare un fatto divenuto ormai scomodo e poi, quando torna a essere
necessario, recuperarlo dall’oblio per il tempo dovuto, negare l’esistenza
della realtà oggettiva e nel contempo tener conto della realtà che si nega –
tutto ciò è indispensabile e necessario”[31].
Il Doppio Pensiero di Orwell, tecnica al contempo appresa e
incorporata, si manifesta, ad esempio, quando abbiamo un “aggressore” ed un “aggredito”
quando a invadere al termine di dieci anni di scontri feroci sono i russi, ma
non lo abbiamo quando sono i turchi o gli israeliani, contro siriani, o contro
i libanesi e i sempre “vuoti” palestinesi. Ma, sapremo per certo che ancora li
avremo quando qualcuno proverà a rispondere.
 |
| George Orwell |
Tornando alla nostra storia, mentre in Palestina Begin avvia e
combatte con metodi di guerriglia l’occupazione inglese, si realizza un
complesso braccio di ferro tra i ‘mandatari’ e i loro partner di oltre oceano.
Nel tentativo di conservare l’equilibrio, infatti, gli Inglesi avrebbero voluto
frenare il ritmo dell’immigrazione ebraica, ma gli americani spingono perché acceleri.
Questo è il contesto nel quale si insedia il nuovo governo laburista
dell’immediato dopoguerra, Attlee inizialmente sembra voler rompere con il
passato imperialista, ma quasi subito si accorge che le condizioni economiche
disastrose della Gran Bretagna richiedono anzi un inasprimento dell’estrazione
di valore dalla periferia. Gli sbalorditivi costi della guerra rendeva
necessario accedere costantemente a nuovi prestiti statunitensi che, per l’opinione
pubblica d’oltre manica erano sempre più difficili da erogare. È il contesto
drammatico del negoziato di Bretton Woods, nel quale i temi sono il ‘libero
scambio’ richiesto dagli americani e il ruolo della sterlina, ancorato strettamente
alla cosiddetta ‘preferenza imperiale’[32]. Infatti,
alla fine della guerra circa la metà del commercio mondiale era negoziato in
sterline, e queste rappresentavano l’80% delle riserve monetarie dei pesi del
mondo. Al contempo, però, la potenza produttiva che poteva sostenere questo ruolo
era ormai compromessa. In sostanza la Gran Bretagna non aveva alcuna
alternativa, se voleva sopravvivere, di usare le politiche monetarie, insieme a
scambi commerciali privilegiati, per trarre beneficio dall’impero (che, d’altra
parte, aveva un enorme costo per tenere in piedi la struttura repressiva).
Quasi subito anche gli americani si accorgono che, nelle mutate
condizioni del dopoguerra, in cui la guerra di Corea mostra il livello della
sfida rappresentata dai paesi comunisti, l’impero serve anche a loro ai fini di
contenimento. Quindi alla sterlina viene concesso di sopravvivere.
 |
| Great Calcutta killlig |
Nell’immediato dopoguerra si tengono i negoziati per l’emancipazione dell’India, ormai non più rinviabile, anche grazie alla presenza di centinaia di migliaia di ex soldati di ritorno, ma si cerca un accordo per tenerla comunque nel Commonwealth. Si realizza una drammatica divaricazione tra mussulmani e indiani, che porterà ai due stati reciprocamente ostili sino ad oggi del Pakistan e dell’India. Passaggi chiave sono la morte di Bose in un incidente aereo, quella di Gandhi in un attentato, quasi subito dopo l’indipendenza, ed il processo agli ufficiali dell’Ina che vede una enorme mobilitazione militare indiana, la quale segnala che il vaso è pieno. Segue il “Great Calcutta killlig”, contri etnici che portano ad almeno 6.000 morti nel paese e danno il via ad un esodo nelle due direzioni, per la separazione delle comunità religiose. Quel che era accaduto è che i complessi metodi di coesistenza tra indù e mussulmani, da secoli negli stessi territori, negoziati e consuetudinari, erano stati dissolti dall’occupazione inglese. Come accade in Palestina erano stati sostituiti da uno schermo di repressione che, quando sollevato, lasciò le comunità le une davanti alle altre.
Il 15 agosto 1947 avviene il passaggio dei poteri, accompagnato da
un enorme processo di distruzione dei documenti compromettenti.
 |
| Attentato al King David Hotel |
In Palestina, appunto, nello stesso periodo, la cooperazione
anglo-americana porta progressivamente a spostare l’equilibrio in favore
ebraica. La potente influenza della lobby sionista sul governo americano, che la
Elkins documenta in nomi e circostanze, forza gli inglesi ad abbandonare gli
arabi al loro destino. Si tratta di stare tra due martelli. Quello ebraico è,
però, più forte: i sionisti dispongono di 45.000 uomini in armi di cui almeno
9.000 sono ottimamente addestrati. Le forze dell’Yishuv attaccano tutte le
infrastrutture inglesi, ferrovie, installazioni petrolifere, caserme. Il governatore
inglese, Bevin, risponde con la guerra. MacMichael avvia una violentissima
campagna di coercizione terroristica, alla quale Begin replica con la bomba che
distrugge il King David Hotel di Gerusalemme.
Qui cade, dopo la vicenda della Exodus, i pogrom a Tel Aviv, le
squadre speciali inglesi, l’enorme massa di denaro che la Palestina inghiotte
per tenerla sotto controllo, la Risoluzione 181 delle Nazioni Unite, che
dichiara la divisione in due stati indipendenti. Il 14 maggio 1948, mentre Orwell
scrive il suo libro, la Gran Bretagna esce dal pantano palestinese. Immediatamente
scoppia la guerra tra arabi ed ebrei sionisti e gli arabi la perdono, 800.000
persone lasciano il paese.
Altre tragedie si tengono in quegli anni in Costa d’avorio, dove
gli attori sono Kwame Nkrumah e Robin ‘Occhio di stagno’ Stephens, reduce da un
processo per le torture ai nazisti processati a Norimberga, e in Malesia.
Le elezioni del 1951 vedono la sconfitta labourista e l’incrudirsi
della crisi malese, nella quale vengono impiegati 30.000 uomini, proprio mentre
la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e le Convenzioni di Ginevra
imbarazzano Colonial Office e Foreign Office. Sir Gerald Templer mette in
essere tutte le raffinate e brutali tecniche anti-insurrezione apprese in un
secolo di dominio coloniale, ma questa volta sono mostrate in una serie di
coraggiosi reportage di denuncia. Allora il Colonial Office decide di cambiare
retorica, e inventa un bellissimo esempio di bipensiero: l’azione deve
portare a conquistare “cuori e menti” e a “sviluppare la comunità”. A tal
fine sono erogati fondi che portano alla creazione dei “villaggi di Templer”,
nei quali la tradizionale vita comunitaria malese, con la sua agricoltura di
sussistenza inserita nella natura, viene tradotta in più civilizzati grandi
villaggi di centinaia o migliaia di persone, accuratamente sorvegliate e
recintate. Un altro modo per riclassificare i campi di concentramento e le
pratiche messe in essere contro gli afrikaneer alcuni decenni prima. Si tratta
di ingegnerizzare uno stile di vita che riduca l’indipendenza di villaggio e
faccia cessare il suo appoggio alla guerriglia.
Similmente in Kenia, dopo l’omicidio del leader locale Woruhin,
nel 1952, una guerra civile e coloniale al tempo vede l’emersione del movimento
dei MauMau (un giuramento) che incendia il paese. Gli inglesi rispondono di
nuovo creando campi di prigionia di massa, con una precisa gerarchia basata
sulla maggiore o minore affidabilità dei prigionieri e usando una forza legalizzata
(ma illegale e coperta dall’amnistia di Churchill) contro quelli più radicali. Si
tratta della “tecnica della diluizione”[33].
In questo modo, tra la difesa della grande missione civilizzatrice
del mondo intero, la nuova religione del nazionalismo imperiale, la spinta
statunitense alla liberalizzazione dei commerci e la conseguente minaccia alla
sterlina, che si arriva alla “Crisi di Suez”[34]. L’Inghilterra
e la Francia inviano un corpo di spedizione per difendere il loro controllo del
cruciale passaggio, ma questo avviene proprio durante una crisi valutaria che
impone di ricorrere, come sempre, a prestiti statunitensi. A questo punto Eisenhower
salva di nuovo alla sterlina, ma, questa volta, impone l’immediato ritiro dall’Egitto.
Le conseguenze geopolitiche ed economiche sono enormi: diviene chiaro che le
superpotenze sono ormai solo due, gli Stati Uniti e l’Urss, la centralità
monetaria della sterlina e delle colonie non può più essere mantenuta.
È la scena finale dell’Impero, di qui si arriva al discorso di
Powell.
[1]
- Caroline Elkins, Un’eredità di violenza. Una storia dell’imparo britannico,
Einaudi Torino 2024 (ed. or. 2022), p. 785.
[2]
- In Elkins, op.cit., p. 797.
[3]
- George Orwell, fermo oppositore interno dell’imperialismo inglese e della sua
immorale postura, nel 1948 poco prima di morire sviluppò il concetto di
“Bipensiero” per il quale si tratta di tenere nella mente contemporaneamente
due pensieri opposti, saltando da uno all’altro secondo convenienza, restando
di ciò al contempo coscienti e inconsapevoli.
[4]
- Secondo la famosa formula della poesia di Kipling.
[5]
- Caroline Elkins, Un’eredità di violenza. Una storia dell’impero britannico,
op.cit., p. 19.
[6]
- Cedric J, Robinson, Black marxism. Genealogia della tradizione radicale
nera, Alegre Roma 2023, (ed. or. 1983).
[7]
- Elkins, cit., p. 23
[8]
- Si veda William Sdalrymple, Anarchia. L’inarrestabile ascesa della
Compagnia delle Indie Orientali, Adelphi Milano 2022 (ed. or. 2019)
[9]
- Si veda anche Edmund Burke, Scritti sull’Impero. America, India, Irlanda,
Utet Torino 2008, p. 353 e seg.
[10]
- Burke, op.cit., p. 364
[11]
- La dimenticata rivoluzione haitiana.
[12]
- Si può vedere, in una diversa prospettiva l’opera di Jurgen Habermas, Una
storia della filosofia (2 vol), Feltrinelli, Milano, 2022-24.
[13]
- Elkins, op.cit., p. 72
[14]
- Elkins, op.cit., p. 165
[15]
- Elkins, op.cit., p. 297
[16]
- Nnamdi Azikiwe, Renascent Africa, Negro University Pressi, New York,
1937.
[17]
- Eric Williams, Capitalismo e schiavitù, Meltemi 2024 (ed. or. 1944)
[18]
- Robert James, Cyril Lionel, I Giacobini neri, op.cit.
[19]
- William Du Bois, Le anime del popolo nero, Le Lettere 2007 (ed. or.
1903)
[20]
- Aimé Casaire, Discorso sul colonialismo, Ombre Corte, 2020 (ed. or.
1950).
[21]
- Franz Fanon, Pelle nera, maschere bianche, Edizioni Ets, 2015 (ed. or.
1952)
[22]
- Franz Fanon, I dannati della terra, Einaudi Torino 1962 (ed. or.
1961),
[23]
- George
Padmore. The life and struggles of negro toilers, Tonbridge, London 1931
[24]
- George Padmore, How Britain Rules Africa, Wishart
Books, London, 1936
[25]
- George
Padmore. Africa and world peace, Secker & Warburg, London, 1937.
[26]
- Elkins, op.cit. p. 346
[27]
- Reginald Coupland, Zulku battle piece: Isandhalawana, Tom
Donovan, 1991(ed. or. 1948)
[28]
- Reginald Coupland, India a re-statement, Legare
Street Press, 2023 (ed. or. 1945).
[29]
- George Orwell, 1984, Feltrinelli, Milano 2021 (ed. or. 1949).
[30]
- Orwell, op.cit., p. 229
[31]
- Idem.
[32]
- Elkins, op.cit., p. 432
[33]
- Elkins, cit. p. 676
[34]
- Elkins, cit. p. 702



_Weizmann_LCCN2014712248.jpg)
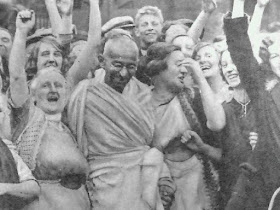
Nessun commento:
Posta un commento